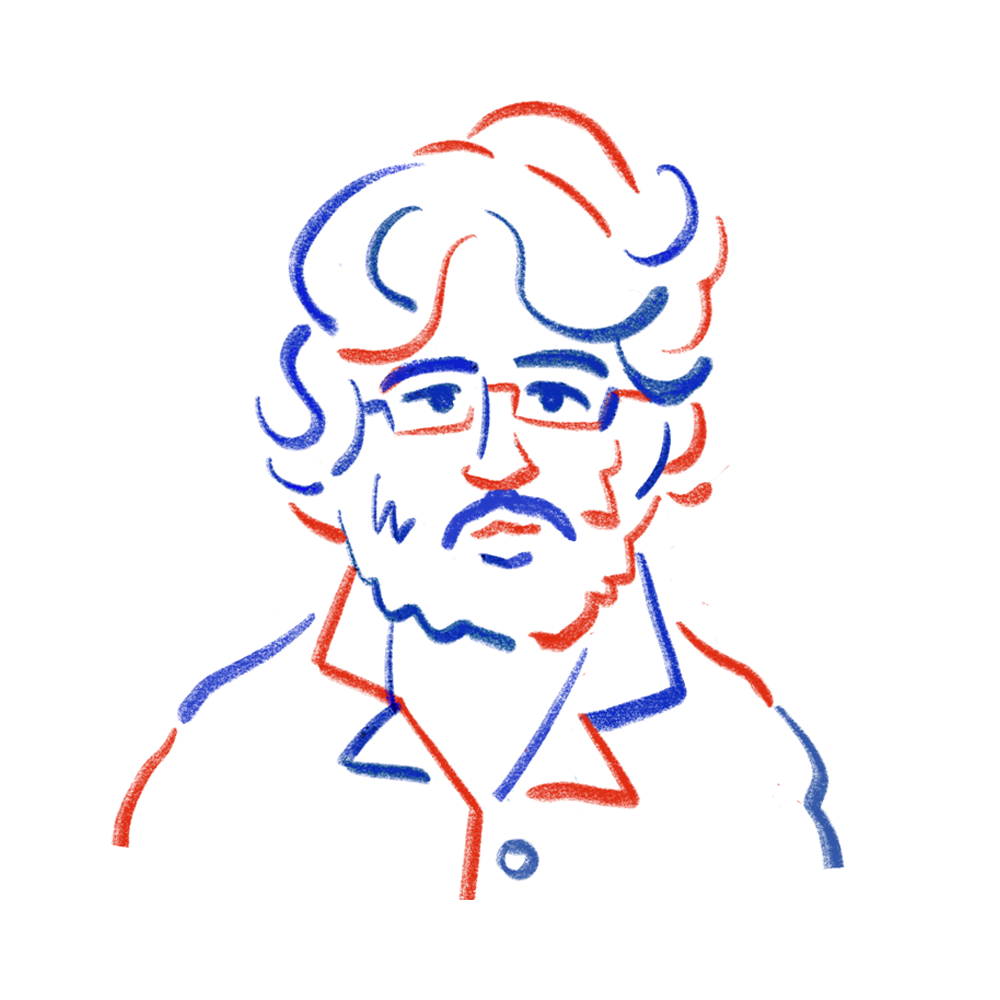Lo sfruttamento del lavoro, il caporalato e le agromafie sono un fenomeno integrato nel sistema di produzione internazionale e trasversale nel mercato del lavoro, in intima connessione con l'organizzazione economica, sociale e politica vigente, rafforzato dal complesso di riforme e di dispositivi normativi promulgati nel corso degli ultimi trenta anni. Sono considerazioni che derivano da un percorso di ricerca-azione condotto sul campo da circa quindici anni che mi ha consentito di fare esperienza diretta di lavoro come sociologo e bracciante sotto vari padroni italiani e caporali immigrati, di dialogare con migliaia di braccianti, uomini e donne, di indagare aspetti originali del padronato, del caporalato e dello sfruttamento, e di sviluppare modalità di contrasto allo stesso, come scioperi, occupazioni e vertenze sociali, ancora oggi innovative nel panorama nazionale e internazionale. Discutere di sfruttamento e caporalato significa anche aggiornare una riflessione che non può continuare a considerare il fenomeno come marginale, periferico, non normato o espressione di un capitalismo arretrato. Al contrario, siamo pienamente dentro il sistema capitalistico globale e nel contempo in un conflitto sociale, politico ed economico, a volte anche giudiziario, tra chi continua a fatturare milioni di euro interpretando il ruolo del padrone e a volte del padrino, e chi, soprattutto lavoratori, sindacati, alcune Procure e alcune associazioni, ha deciso di capire quest'organizzazione e di contrastarla con le armi della conoscenza, della mobilitazione e della denuncia.
Questo primo articolo riprende alcuni stralci del libro “Sotto Padrone” (Fondazione Feltrinelli, 2019) che racconta la storia di Manjeet, bracciante indiano residente nell'Agro Pontino reso schiavo nell'Italia democratica fondata sul lavoro e di come è tornato alla libertà.
“...Erano diversi giorni che un lavoratore indiano mi chiedeva di seguirlo. “Indiano sta male, indiano sta male”, continuava a dirmi...“Va bene, andiamo”, gli dissi. “No oggi. Domani. Domani il padrone torna a Roma. Domani alle 18 andiamo?” “Va bene”, risposi e gli diedi appuntamento il giorno dopo, sempre al tempio. Lo andai a prendere con la mia auto. Avevo una vecchia Ford Fiesta 1.2 che mi permetteva di entrare in luoghi in cui auto più nuove e meglio tenute avrebbero sollevato sospetti. Mi portò nei campi tra Pontinia e Sabaudia...Mi fece fermare a circa trecento metri da un cancello chiuso da un lucchetto molto grosso, con una recinzione in filo spinato su pali di castagno, che intendeva chiaramente sbarrare l’accesso a chiunque…“Vieni, nessun problema. Vieni! Padrone non c’è. Indiano è più avanti”, mi disse in un italiano con accento punjabi. Mi fidai. Entrai. Era pieno di sterpi tra i quali ogni tanto spuntava un aratro arrugginito, qualche tubolare abbandonato da anni, poi ruote di trattore e in lontananza una serie di magazzini. La loro copertura, come spesso capita in quella zona, era in eternit...Arrivammo davanti a uno di quei magazzini. Era costruito con dei blocchetti grezzi messi l’uno sull’altro e tenuti insieme con della calce preparata in modo grezzo. Davanti a noi una porta di ferro marrone chiusa con un lucchetto di medie dimensioni. Sopra una finestrella con delle grate, anch’esse in acciaio. Guardai il mio compagno indiano che iniziò a parlare in punjabi. Rimasi in silenzio. Rispose una voce d’uomo. Iniziarono a parlare in punjabi. No, non era possibile. Era un uomo. Un uomo abitava in quella bettola di blocchetti grezzi di cemento, con una sola finestrella, sperduto in mezzo a quella campagna inaccessibile. Mi avvicinai alla porta e con tono incredulo e sbigottito urlai: “Ciao, come stai? Chi sei?”… stavo parlando a un uomo chiuso in una gabbia quattro metri per quattro dove forse, nella migliore delle ipotesi, fino a qualche anno fa venivano tenuti i maiali o gli attrezzi. “Ciao! Manjeet, sono Manjeet.” Mi resi conto, proprio in quell’istante, di trovarmi davanti a una realtà che pensavo lontana nel tempo e scomparsa per sempre: lo schiavismo, per di più in un Paese che si dichiarava democratico. Provai a forzare quel lucchetto, ma era troppo pesante. Girai intorno alla baracca, tra erbacce che mi arrivavano alle ginocchia e odori poco gradevoli...Tutto ciò che avevo ascoltato sino ad allora dalla viva voce dei braccianti si condensava nelle emozioni estreme che stavo provando in quel momento: rabbia, dolore, sorpresa, indignazione, paura, ansia...Presi gli attrezzi che si usano per cambiare la ruota di scorta. Ricordo che c’era una chiave di acciaio, che da un lato finiva a punta e dall’altro a stella. Era abbastanza resistente, anche se corta, ma con l’aiuto del masso che avevano trovato potevo forse raggiungere il risultato sperato. Tornai da Manjeet che, nel frattempo, era rimasto in silenzio e aveva lacrime che scendevano lungo il viso. Era la prima volta che un italiano stava lavorando così per lui e Manjeet, e senza chiedere in cambio nulla. Gli chiesi di passarmi il masso che avevamo riposto lì vicino, mentre cercavo di incastrare quella strana chiave tra la parete e il lucchetto...In quel preciso momento stavo violando non so quali e quante leggi. Violazione della proprietà privata e scasso, sicuramente. La cosa giusta da fare era però liberare quell’uomo. Tutto il resto veniva dopo. Al primo colpo mi cadde il masso dalle mani e con esso anche la chiave...Al terzo tentativo il lucchetto si ruppe e Manjeet fu libero. È stata una delle azioni più intense e vere che abbia mai fatto in vita mia. Manjeet uscì e con occhi lucidi mi ringraziò chinandosi prima ai miei piedi, con gli occhi pieni di lacrime e poi stringendomi forte la mano. Poi abbracciò quello che pensavo essere, sino ad allora, un suo amico. Avrei capito solo qualche giorno dopo, invece, che quell’uomo di nome Deep era il fratello maggiore. Deep era venuto in Italia prima di Manjeet, aveva trovato lavoro e poi aveva chiesto ai soliti trafficanti, in cambio di una somma che nel 2010 era di 10.000 euro, di far arrivare anche il fratello neomaggiorenne...Erano in sostanza caduti in trappola, una trappola senza apparente via d’uscita. Mi dissero alcuni suoi amici indiani, che più volte Manjeet gli aveva confidato di non farcela più e che desiderava suicidarsi. Fu suo fratello Deep a salvargli la vita. Non lo lasciò solo neanche un attimo. Poteva piovere o fare un caldo infernale, ogni sera Deep andava con la sua bicicletta dal fratello per fargli sentire la sua voce, rincuorarlo, dargli coraggio e portargli del cibo. Manjeet viveva davvero in un tugurio, illuminato da una sola lampadina che penzolava dal centro del soffitto. Dentro quel ripostiglio c’era una brandina da campeggio, un rubinetto, due comodini di legno dove teneva i suoi vestiti e qualche rivista indiana che probabilmente il fratello gli aveva passato dalle grate della finestra. L’odore era fortissimo. In un angolo, una serie di scarpe e di ciabatte che Manjeet usava per lavorare. Ogni mattina, mi disse, il padrone apriva la porta di quel tugurio, gli portava del latte e del pane e poi lo mandava a lavorare sotto le serre...Sotto le serre Manjeet coltivava zucchine, pomodori, insalata, broccoletti, ravanelli. Poi c’erano degli alberi da frutta, soprattutto meli e peri, degli olivi e forse una decina di alberi di mandarini...Il padrone gli portava anche una cassa d’acqua ogni due o tre giorni. Il bagno era la campagna e per lavarsi, oltre al rubinetto, doveva andare all’esterno, sotto quel porticato di eternit, dove un tubo incastrato nella rete, a circa due metri d’altezza, fungeva da doccia...Gli feci prendere i pochi vestiti che aveva, le scarpe e i giornali e dissi ai due di avviarsi verso l’auto. Tornando in auto mi voltai un paio di volte indietro, quasi per assicurarmi che tutto ciò che avevo vissuto fosse vero. Ed era vero, incredibilmente vero. Durante il viaggio Deep aveva un sorriso sereno e occhi lucidi. Spesso mi diceva: “Grazie Marco, tu nostro fratello”. Manjeet sorrideva anche lui e si guardava intorno. Li portai entrambi al tempio sikh di Sabaudia. Avrebbero dormito insieme dopo otto mesi di sofferenze, nella stessa stanza. Ero felice di quel risultato...”.
Testo tratto dal libro “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana”, di Marco Omizzolo