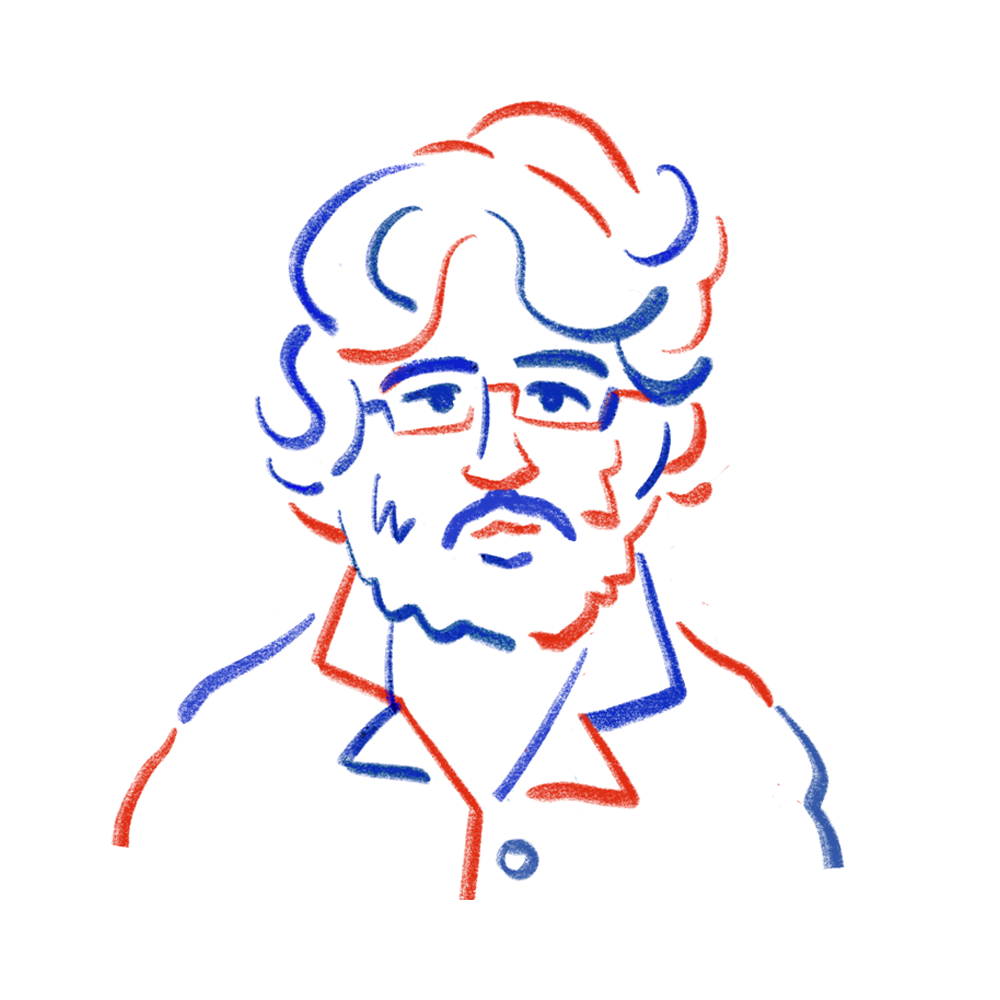07 marzo 2021
Luca Greco, nato a Termoli nel 1979, dottore di ricerca in filosofia teoretica, sui banchi del liceo incontro Walter Benjamin e la sua flânerie. Sindacalista della CGIL, educatore, no global ai tempi del 2001, ricercatore universitario mancato, volontario, cooperante, fondatore della sezione ANPI "Vittorio Arrigoni". “Le strade dell’Apartheid” altro non è che il suo ennesimo tentativo di raccontare la storia dalla parte degli oppressi.
"Le strade dell'Apartheid" intercetta e intreccia in modo appassionato e competente le storie di popoli che vivono forme molto gravi di emarginazione, segregazione e violenza. In primis, perché questa esigenza? Da dove viene questo suo bisogno, pienamente condivisibile, di raccontare le ingiustizie?
“Tutto è nato dalla necessità di mantenere fede ad una promessa. Una promessa fatta agli uomini e alle donne che durante i viaggi ho incontrato. Tutti mi hanno chiesto di raccontare ciò che i miei occhi avevano visto e le mie orecchie avevano udito. La fotografia mi è parsa lo strumento a me più vicino per costruire questo racconto. “Le Strade dell’Apartheid” nasce come mostra fotografica. Crema, Ferrara, Bologna, Cinisi, Genova, Parma, Macomer, Padova, Milano, Marina di Camerota, Tricase: queste sono solo alcune delle città che mi hanno ospitato. Nel mentre, “Le strade dell’Apartheid” è diventato parte di uno progetto teatrale più ampio ed articolato: lo foto si sono fuse alle parole dei drammaturghi Chiara Tarabotti e Davide Sormani dando vita a “Poeti Troiani”, spettacolo che ha debuttato nel 2018 a Macomer. E poi è arrivato il libro. Una promessa mantenuta, dunque. Ma non solo. L’altra necessità è stata quella di evitare che queste storie venissero dimenticate, di mantenere accesa una fiamma di speranza e ricordo, di “fare memoria”. Una memoria che è da intendersi nel duplice significato che ha nella teologia ebraica: “memoria” non solo come ricordo di ciò che è avvenuto, affinché non cada nell’oblio, ma anche “memoria” come tentativo di portare a compimento, di realizzare, ciò che in passato non si è potuto fare. Una memoria “attiva” che prova a creare nell’oggi le condizioni per cui gli sconfitti di ieri, vincano. Questo ragionamento, rimanda direttamente al “conformismo” dei vincitori con il quale si costruisce la storia. La storia è dei vincitori, si dice. Esiste però un’epopea degli sconfitti che, per il solo fatto di non aver vinto, rischiano di scomparire anche dal ricordo. “Le Strade dell’Apartheid” ambisce a raccontare questo lato nascosto, prova a narrare i fatti dalla parte di chi ha perso, ma che non è ancora stato vinto”.
Cosa ha significato attraversare territori ed incontrare situazioni e persone gravemente emarginate e discriminate?
“C’è una parola che più di tutte mi risuona dentro ogni volta che ripenso a quello che ho visto nei miei viaggi ed è “dignità”. La volontà di palestinesi e saharawi di condividere il niente che hanno, il sorriso con cui lo fanno, è di una potenza incredibile. Rimanda direttamente a quel senso di comunanza che normalmente scatta fra persone che vivono condizioni di estrema emarginazione ed è ciò che lega chi condivide lo stesso sentimento di oppressione. Restare, anche se per poco, accanto a loro mi ha obbligato a scegliere: di fronte ai murales di Belfast, davanti alle file palestinesi dinnanzi ai checkpoint israeliani, di fronte al muro marocchino che taglia in due il Sahara Occidentale non si può restare indifferenti. È necessario prendere una parte, diventare partigiani: “Le Strade dell’Apartheid” è il risultato di questo mio schierarmi. Percorrere questi sentieri, assieme fisici e mentali, mi ha restituito una grande speranza: se – nonostante l’occupazione, la segregazione, le espulsioni, le bombe – le donne e gli uomini palestinesi, saharawi ed irlandesi continuano ad esistere e resistere, allora significa che non è tutto perduto per sempre, che l’umanità di cui parlava Vittorio Arrigoni è ancora viva e pulsante, che possiamo ancora modificare il corso degli eventi”.
Oggi il termine apartheid sembra un concetto del passato ed invece il suo libro ricorda a tutti che esistono ancora situazioni gravemente lesive della dignità umana. Oggi apartheid, emarginazione e segregazione sono applicabili anche in Italia? E nel caso in che modo?
“Penso che in questo caso, come in tanti altri, valga la pena partire proprio dalla parola. Secondo il dizionario Treccani il termine apartheid indica “qualsiasi tipo di emarginazione attuato nei confronti di persone o gruppi considerati diversi o inferiori”. Direi che, partendo da questa definizione, è senz’altro possibile affermare che in Italia ci siano svariate forme di apartheid, basti pensare alle discriminazioni di genere in campo lavorativo, alle quasi inesistenti possibilità di autorealizzazione per chi è diversamente abile o ai differenti diritti che regolano le possibilità di vita fra chi è nato in Italia e chi in Italia prova ad arrivare. Più in generale, penso che la società odierna, abbia il suo fondamento ontologico nella marginalizzazione: al potere serve consentire alla collettività di individuare nel diverso il “nemico” su cui riversare le colpe della propria stessa condizione. Se poi il “nemico” è una minoranza – etnica, sessuale, lavorativa – è anche più facile colpirlo. Tutto questo è intimamente legato alla filosofia della storia che sottende le società basate sul predominio del progresso. Walter Benjamin, ci viene ancora una volta in soccorso. Nelle sue Tesi sul concetto di storia, il “progresso” occupa un posto centrale. In particolare la tesi numero IX descrive il meccanismo di funzionamento della società borghese paragonandola al movimento dell’Angelus Novus, il protagonista di un quadro di Paul Klee. In questo dipinto l’Angelo è spinto in avanti in maniera inesorabile da un vento che soffia alle sue spalle, egli vorrebbe fermarsi a ricostruire le macerie che vede dietro di se, ma non gli è possibile. Ecco la nostra società funziona proprio in questa maniera: avanza inesorabile verso il futuro distruggendo ciò che essa stessa aveva appena creato, in un rinnovamento continuo che in realtà produce solo macerie. Ma queste macerie – i marginali, i diversi, i senza casa, i vinti dalla storia, gli oppressi – sono necessarie all’avanzata del progresso. In questo senso la società contemporanea ha bisogno dell’apartheid”.
Provo a scrivere alcuni nomi e vorrei che lei esprimesse le sue considerazioni: Vittorio Arrigoni, Jerry Masslo, Rachel Corrie.
“Faccio un piccola premessa. Da buon benjaminiano, mi interessano da sempre le correspondances care a Baudelaire fra alcuni eventi all’apparenza lontani o diversi fra di loro. Parto allora da Rachel, uccisa il 16.03.2003. A Milano nello stesso momento, lame fasciste uccidono Davide “Dax” Cesare. Due vite strappate dalla violenza, fascista e di Stato. Per entrambi non ci sarà giustizia. Di Rachel mi hanno sempre impressionato i suoi diari, da essi emerge come la militanza fosse per lei una necessità, una sorta di imperativo categorico kantiano. Si è posta davanti al bulldozer che l’ha poi travolta ed uccisa perché non poteva fare altrimenti. Jerry è stato uno dei tanti “invisibili” che popolavano e ancora popolano le nostre campagne, vittima sia dell’apartheid sudafricana che di quella nostrana. Jerry aveva capito che alla base della sua condizione lavorativa c’era la sfruttamento mafioso dell’uomo sull’uomo. Ed aveva cominciato a dirlo. Vittorio l’ho conosciuto. Assieme ad alcuni compagni e compagne, organizzammo a Ferrara la presentazione del suo “Restiamo Umani”. Pipa, kefia e cappello sempre ben calzato. Raccontava una guerra e ogni tanto sorrideva. “In lui ridono tutti i mali del mondo”: così Pirandello descriveva Don Chisciotte, così io ricordo Vik. In uno dei suoi ultimi articoli per “Il Manifesto”, Vittorio parlava di un gruppo di giovani gazaui che non si riconoscevano né con Hamas né con Fatah e che anzi cercavano una terza via per essere diversi da entrambi. Vittorio era scomodo proprio per questo, perché dava voce ai non allineati ed è per questo che per me “è stato fatto uccidere”: non si entra ed esce da Gaza senza che chi lì ha il potere ti consenta di farlo. Quest’anno ricorrono i 10 anni dal suo assassinio. Ed a proposito di date, a luglio del 2021 saranno trascorsi 20 anni dal G8 genovese. Ed allora, accanto a Rachel, Vik e Jerry, un quarto nome lo propongo io ed è quello di Carlo Giuliani. Io in quei giorni ero a Genova, ed in piazza Alimonda torno ogni 20 luglio. Da vent’anni. La verità giudiziaria sull’assassinio di Carlo non ci sarà mai. Quella storica si. Basta guardare le immagini di Piazza Alimonda per capire che la camionetta non era bloccata, che Carlo era distante dalla camionetta, che la pistola era puntata ad altezza uomo ben prima che Carlo recuperasse l’estintore. Carlo, come Rachel, come Vittorio e come Jerry ha provato a difendere le persone attorno a se. Una delle foto del libro cui sono più legato si intitola “infanzia Saharawi” ed è stata scattata nei campi profughi. Quella scuola, costruita grazie al contributo dell’Auser e della CGIL, è intitolata proprio a Carlo Giuliani. Sapere che, nel mezzo del nulla che è il deserto dell’Hammada, esiste una luogo per bambini che porta il suo nome, mi fa sentire Carlo sempre accanto. Nelson Mandela diceva che “un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare”: Vittorio, Rachel, Jerry e Carlo io continuo a vederli così, sognatori di un’utopia ancora irrealizzata.
Nel suo volume si trova un rimando continuo, esplicito e implicito, alla libertà. Cosa significa libertà per lei oggi.
“L'allodola, come giustamente diceva mio nonno, aveva uno spirito: lo spirito della libertà e della resistenza.Voleva essere libera, e morì prima di sottomettersi al tiranno che aveva tentato di cambiarla con la tortura e la prigionia. Sento di avere qualcosa in comune con quell'allodola e con la sua tortura, la prigionia e alla fine l'assassinio”. Questo stralcio di uno degli scritti di Bobby Sand penso possa aiutare a inquadrare meglio la questione. Penso che l’idea di libertà non vada confusa con una generica possibilità che ognuno ha di fare ciò che più gli piace, né con il mero “diritto” di rivendicare la propria individualità. Mi si perdonerà se faccio mie le parole di Sandro Pertini, il quale, proprio a proposito di libertà si esprimeva in questi termini: “per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del socialismo, costituiscono un binomio inscindibile: non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Ecco, se a me socialista offrissero la realizzazione della riforma più radicale di carattere sociale, ma privandomi della libertà, io la rifiuterei, non la potrei accettare. Ma la libertà senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana. Mi dica, in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero”. Ecco il senso più profondo della parola “libertà”: si è liberi quando si può scegliere come e cosa si vuole essere, quando si lavora per costruire le condizioni sociali affinché ognuno possa “dare” a seconda delle proprie possibilità ed “avere” a seconda dei propri bisogni. La libertà non è un fatto individuale, ma massimamente collettivo: si è liberi assieme agli altri, non a discapito degli altri. Questa idea mi auguro emerga dalle pagine de “Le strade dell’Apartheid”. La possibilità di scegliere come e dove vivere, di poter autodeterminarsi, di tornare nella propria terra è il grido che ho cercato di raccogliere.
Immagini di trovarsi dinnanzi ad un ragazzo/a di diciotto anni e di dovergli spiegare cosa è l'ingiustizia oggi e come agire per contrastarla. Cosa gli/le direbbe?
“Penso che gli/le parlerei di Gramsci e di Don Milani. Proverei a raccontare loro, attraverso gli scritti di questi due grandi pensatori, che ingiustizia e privazione di diritti vanno spesso di pari passo; che i diritti sono tali se tutti e tutte possono goderne, diversamente si tratta di privilegi; che per dirla alla Guccini, “nel mondo oggi come ieri domina l’ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia”. Per combattere le ingiustizie, bisogna innanzitutto riconoscerle. E per riconoscerle c’è bisogno di consapevolezza e di uno sguardo critico, che non si limiti a registrare ciò che vede, ma che provi a decostruirlo prima e poi a modificarlo. E per far questo c’è bisogno di studio. Direi loro che contrastare le ingiustizie è un atto assieme individuale – perché attiene a scelte, etiche, economiche od ambientali, che compiamo come singoli nel quotidiano – e assieme collettivo. Farei loro l’esempio del Boicottaggio verso il Sud Africa razzista che ha portato alla fine dell’Apartheid: la liberazione di Mandela è figlia anche delle scelte di non acquistare determinati prodotti da parte di intere economie. Non è un caso che lo stato israeliano tema particolarmente il BDS. Questo movimento – BDS è l’acronimo di Boicotta, Disinvesti, Sanziona – mira proprio a colpire i prodotti israeliani fabbricati nelle colonie, illegali per il diritto internazionale, ed a negare rapporti economici e culturali con quelle istituzioni che appoggiano la politica coloniale israeliana. In questo il boicottaggio è uno strumento potente: ogni singolo individuo può contribuire alla sua riuscita, è uno strumento non violento, colpisce l’economia, uno dei motori principali di uno stato. Tutto questo per dire che l’azione a contrasto dell’ingiustizia parte necessariamente dalla presa di coscienza dell’esistenza dell’ingiustizia stessa ed è frutto delle scelte consapevoli che compiamo come individui, scelte che se agite contemporaneamente da più persone si trasformano in azioni collettive.
Quali sono i suoi prossimi progetti? Ci può anticipare qualcosa?
“Ad aprile scorso, in piena pandemia, ho cominciato a lavorare a “Dietro la Maschera”, un racconto per immagini incentrato sui volti delle lavoratrici e dei lavoratori degli ospedali, ritratti nell’attimo immediatamente precedente alla fine del turno di lavoro nei reparti Covid. Mi piacerebbe tornare a Bihac, cittadina al confine fra Bosnia e Croazia, per documentare quello che ora sta capitando sulla “Balkan Route”. Inoltre, assieme ai fotografi dell’associazione “Feedback”, sto lavorando a “Quartiere Ferrara”: progetto collettivo di lungo respiro che mira a raccontare lo spirito della città estense attraverso 12 mesi di scatti incentrati su un singolo tema”.
Foto di Luca Greco che riprende la copertina del libro. Nel 2018 la foto ha vinto la menzione speciale al concorso fotografico dedicato a Guido Orlando promosso da Casa Memoria "Peppino e Felicia Impastato" ed oggi è esposta a casa Badalamenti.