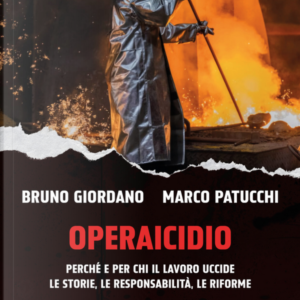È uscito alla fine dello scorso anno il volume dal titolo “Il mio nome è Balbir”[1] scritto a quattro mani – nel senso che poi si approfondirà - dal sociologo e ricercatore dell’Eurispes Marco Omizzolo e dall’operaio agricolo ed ex-schiavo (non in una fantasia da terzo mondo, ma a 80 chilometri da Roma, nell’Agro Pontino) sikh Balbir Singh. Il libro è già stato ampiamente commentato e discusso in sedi qualificate, ed i resoconti di tali dibattiti, come anche recensioni ad opera di riviste o siti on-line, sono facilmente consultabili in rete. Tornerò con qualche osservazione (temo) radicale su tali commenti. Per intanto vale la pena di sottolineare come, tra recensori e commentatori, non ci sia stato dall’inizio dubbio alcuno circa la verità di quanto denunciato, senza bisogno di attendere gli esiti del processo svoltosi a Latina. In larga misura, certo, ciò è merito della giusta fama di rigore scientifico, oltre che di passione militante (ai limiti del pericolo personale) che avvolge Marco. Temo ci sia anche dell’altro.
Brevemente, i fatti. A parlare in prima persona è l’operaio agricolo Balbir Singh, entrato in Italia con regolare permesso, impiegato per qualche tempo nei lavori agricoli della campagna laziale (del resto il posto d’Italia in cui più forte è la presenza sikh) dapprima con regolare contratto poi, dopo la chiusura dell’ultima azienda in cui stava lavorando, caduto nella trappola di un apparente impego regolare nei pressi di Latina, in una fattoria annessa ad un ristorante, quindi dedita solo marginalmente alla produzione per il mercato, ma funzionale piuttosto a sostenere una avviata attività di ristorazione. In altre parole, un posto molto frequentato, non un angolo di campagna remoto. In poco tempo, sequestratigli i documenti - Balbir li aveva spontaneamente consegnati per consentire, a detta del padrone, le pratiche di rinnovo del permesso - la sua situazione si allinea sempre più a quella di uno schiavo, realtà che del resto gli grida ogni giorno, tra una minaccia e una violenza, il padrone, anzi il Padrone. Le condizioni terribili di vita e la paura che accompagnano il malcapitato in ogni momento, come pure gli slanci di ribellione, portandolo a cadere inevitabilmente in uno status di alcoolista, sono scandite nei capitoli che costituiscono la prima parte del libro. La strada verso la salvezza si aprirà in modo affatto fortuito, con l’ingresso nella fattoria di un rappresentante di prodotti agricoli sikh in un momento di assenza del padrone. Balbir riesce ad avvicinarsi per un attimo e a pronunciare due parole nella loro lingua. Si mette così in moto, in particolare dopo l’avventurosa consegna di un cellulare che permette di stabilire il rapporto con Omizzolo, una lunga fase di conversazione clandestina notturna, sorta di esperienza di terapia e di rinascita, che lo aiuterà a riprendere il controllo della propria vita, anche liberandosi dall’alcool, e ad essere pronto al momento della denuncia e dell’irruzione dei carabinieri nella fattoria, ad assumere con convinzione il ruolo di accusatore. Il lungo processo terminerà con la condanna a cinque anni di reclusione dell’ex Padrone (condanna assai blanda, ma comunque superiore a quanto richiesto dal PM), l’indicazione di una cifra di risarcimento (che Balbir sa essere destinato a non vedere mai), ma soprattutto l’apertura di una nuova fase di vita comunque tutt’altro che priva di problemi. Uno dei molti pregi del libro, ai miei occhi anzi tra i maggiori, è proprio quello di guidarci senza false illusioni nel difficile, e non poco periglioso, “dopo”.
Devo prima di andare avanti soffermarmi sulla complessa collocazione di Omizzolo nell’architettura del volume: Marco non gioca al falso scriba, colui cioè che si limiterebbe a riportare quanto affermato dal soggetto secondo una assurda quanto mendace ipotesi di totale oggettivismo. Non è però neppure il vero e unico autore, che si avvarrebbe di un espediente per mettere in bocca ad uno straniero, proveniente tra l’altro da una civiltà lontana dalla nostra, le frasi da pronunciare e il ruolo da giocare. Il libro, spiegherà in una intervista Omizzolo, è stato davvero scritto a quattro mani, perché si tratta dell’esperienza di Balbir, bracciante sikh ridotto in schiavitù nell’Agro Pontino ma è nel contempo la “mia storia personale di come con Balbir siamo riusciti a riottenere libertà e giustizia”[2]. Ciò spiega l’incipit, in cui Balbir rivolgendosi a Marco[3] gli chiede di raccontare tutto ciò che lui gli dirà, usando però il presente anche per la fase, ormai per fortuna risalente, della schiavitù (semi-)conclamata. Nei primi capitoli Omizzolo è dunque davvero un narratore di esperienza altrui, esperienza che si fa, come già detto, comune nella seconda parte, quando anche il tono, inevitabilmente anche lo stile, cambia diventando forse più avventuroso.
Nei primi capitoli Balbir racconta la sua condizione di vita dopo l’intrappolamento, accenna con addolorato riserbo al periodo di sostanziale etilismo, ma soprattutto al perenne stato di sospensione in cui si è per lunghi anni trovato (nella notte gridava forte il suo nome per ricordare di essere ancora vivo)[4]. Le sue condizioni materiali sono drammatiche, e si collocano in un contesto generale che vorremmo giudicare assurdo: la roulotte sgangherata in cui vive, priva di bagno e di riscaldamento, come di ogni forma di ventilazione, è a 10 metri dalla casa del padrone, adiacente al ristorante molto frequentato. Ma nessuno vuole vedere. E Balbir grida (p. 26): “Quante volte mi sono domandato: ma io chi sono? Ho passato più anni in Italia che in India, ma non sono cittadino italiano. Lavoro come uno schiavo, eppure in Italia la schiavitù è vietata. Siete diventati più ricchi grazie a me, ma mi considerate un criminale… Mi chiedete soldi per rinnovare il permesso di soggiorno, ma se non lo rinnovo lo perdo per sempre e mi mandate in galera”,
Il racconto comincia a riportare date, e quindi a farsi “azione”, a partire dal Natale 2016. Quattro brevi capitoli scandiscono l’avvicinamento ad un 25 aprile che sarà anche nel suo caso di (premessa ad un percorso di) liberazione. Nel primo descrive il modo in cui riesce a sopravvivere: praticamente litigando con gli animali da cortile (galline) e da allevamento (maiali) per i resti del ristorante che il padrone butta agli animali la notte. Presenta poi gli altri due schiavi, uno dei quali, ucraino, si trova nella sua stessa condizione, mentre il terzo, essendo italiano (sardo) suscita meraviglia per la passività di fronte alla riduzione in schiavitù. Il clima di paura che avvolge la fattoria/ristorante è ben esemplificato: un giorno il toro che doveva essere accudito dall’ucraino lo carica, gli altri due a stento portano fuori dal recinto il compagno di sventura, il padrone sopraggiunto vieta di portarlo in ospedale; ordina invece di rimetterlo nella sua roulotte aspettando che si riprenda. Ove ciò non avvenga, e l’ucraino muoia, si dovrà scavare una buca e buttare dentro il corpo. Questo, scopriamo seguendo Balbir[5], è l’andazzo generale nei luoghi dove lavorano stranieri irregolari: i padroni preferiscono lasciarti morire e poi, se non riescono a far sparire il corpo, dire che è stato a causa della superficialità o dell’imperizia dello schiavo. Insomma, “noi schiavi viviamo continuamente sul confine tra la vita e la morte” (p. 46). Balbir è picchiato, di continuo[6]. Si rende conto così che ogni passo del padrone rientra nel lucido progetto di trasformarlo in schiavo anche nell’anima, ricorrendo ai vari mezzi a disposizione: violenza, fame[7], stato segregativo, stato giuridico di clandestino. Gli si fa evidente anche l’importanza di liberarsi della bottiglia di whisky.
Arriva il fatidico 25 aprile. Alle tre del pomeriggio, quando Balbir ha appena finito di pulire la stalla, entra nel cortile un camioncino, che si ferma. Non è un episodio raro: di solito si tratta di rappresentanti di prodotti alimentari per il ristorante, o di consegne di granaglie per animali[8]. Questa volta però l’occhio di Balbir vede, appeso allo specchietto retrovisore, un pendente che porta il simbolo della sua religione, il sikhismo[9]; l’uomo al posto di guida è solo, porta un turbante. Quando lo schiavo gli si avvicina con il cuore in gola, abbassa il finestrino e dice di essere un rappresentante di prodotti italiani e indiani che potrebbero interessare il “proprietario d’azienda” (sic!). Balbir spiega in fretta (il padrone potrebbe comparire da un momento all’altro) la situazione di schiavo in cui versa, l’altro scrive il suo nome in un foglietto, dice brevemente di essere il capo dell’associazione Comunità indiana del Lazio che ha da poco organizzato uno sciopero a Latina per gli indiani sfruttati. Balbir entra in uno stato di confusione ed eccitazione ad un tempo.
La vera svolta avverrà il primo maggio, quando il camioncino ritorna: l’indiano parla brevemente con il padrone, che non è interessato ai suoi prodotti e si allontana. Andandosene, il conducente trova il modo di passare vicino a Balbir e sussurrargli che a mezzanotte passerà fuori dall’azienda con un’auto e dovrebbe farsi trovare. Il racconto di come avviene la presa di contatto (indiretta) notturna è il passaggio più coinvolgente, ci tornerò alla fine. L’auto passa ed abbandona un sacco nero di spazzatura, come quelli che spesso Balbir apre di notte per tirarvi fuori qualcosa da mangiare, salvo rimetterli al loro posto. Questa volta però ci sono cose per lui, doni che allo schiavo paiono meravigliosi (!): merendine, dolcetti, fette di pane biscottato con marmellate, dolci secchi, succhi di frutta ed acqua. Ci sono anche una felpa ed una sciarpa pesante, un plaid, un quaderno con due penne e, soprattutto, un cellulare con ricarica.
Qui comincia il percorso di riscatto, o meglio di riconquista dello status di uomo libero, da parte dello schiavo. Il cellulare contiene dei video: di uno sciopero a Latina, di un indiano che gli spiega nella sua lingua che stanno lavorando per lui e deve aver fiducia e pazienza, ed un terzo in cui Omizzolo stesso si presente, lo saluta, lo invita ad usare il cellulare per stabilire un contatto. Da questo momento, per tutto il mese di maggio, si sviluppa una sorta di pedagogia degli oppressi, che all’inizio vede Marco insegnare a Balbir, in una lezione da remoto, le cose minime sull’Italia, sulla situazione, su cosa bisognerà operare per portare denunce che possano avere successo, sulle storie di persone che si trovavano in situazioni simili a quelle di Balbir ed hanno riconquistato la libertà. È quindi una relazione inizialmente verticale, una lezione frontale operata da remoto, che però, come spiega Omizzolo nell’intervista sopra citata, diventa presto percorso di crescita a due[10]. Alla fine di maggio Balbir è pronto, sia a denunciare il padrone, sia ad assumersene le possibili conseguenze. Nel corso di questo apprendistato di rinascita, appare costante il suo rifiuto per la falsa soluzione della fuga (già emergeva all’inizio) che, nella situazione, non porterebbe con sé nulla di buono. Balbir, lo accenna a più riprese, ha più spesso preso in considerazione l’ipotesi opposta, quella della soluzione violenta, definitiva. Verso sé stesso, verso il Padrone? Fino all’entrata in scena di Omizzolo, l’ipotesi, nelle due varianti[11], gli si è posta spesso.
Proprio alla vigilia dell’irruzione dei carabinieri Balbir è stato frustato come mai prima, questa volta in presenza di alcuni fornitori, restati immobili a guardare (godersi?) la scena. Arrivati i carabinieri, lo stesso Padrone gli si avvicina dandogli istruzioni di dichiarare che sta bene, che ha cominciato a lavorare da pochissimi giorni, che non ci sono problemi in azienda e che si trova bene, minacciando vendetta da parte dei suoi amici mafiosi se lo tradisce. Qui le vie di Balbir e degli altri due schiavi si separano definitivamente, perché quelli non vogliono denunciare e avere giustizia. Vogliono solo scappare, approfittare della situazione per andar via e lasciarsi l’incubo alle spalle. Forse per questo Balbir non ha mai dato loro un nome nel suo lungo racconto, neppure di comodo. Sono ombre, comprimari, schiavi in fuga, se vogliamo. Balbir va con i carabinieri al comando, e inizia la sua lunga deposizione, preparata nell’ultima settimana nella conversazione notturna con Marco. Naturalmente, il rifiuto del sardo e dell’ucraino a seguire questo percorso non giova, privando di una conferma diretta la testimonianza. Interessante come durante la deposizione egli sia attanagliato dalla paura, perché non sa se verrà trascritto esattamente il suo discorso[12]. Nei mesi successivi Balbir si trova di nuovo in uno stato di sospensione, ma questa volta esternalizzata per così dire. Nel senso che lui sa benissimo chi è, che scelta ha compiuto, cosa si deve aspettare, ma ha l’impressione – così diffusa tra i testimoni di giustizia! – che lo Stato lo abbia abbandonato, una volta ottenuta la testimonianza. Il ritardo nel rilascio di un nuovo permesso di soggiorno lo getta in una preoccupazione spasmodica[13]. Interessante, nella descrizione di tale fase, l’elenco delle novità più belle nella sua propria fatto da Balbir: oltre naturalmente al poter ristabilire i rapporti con la propria famiglia, il poter andare a pregare nel tempio sikh, il non doversi più rompere la schiena e non temere le punizioni fisiche dal padrone, e poi mangiare cibo indiano in piatti puliti, mangiare frutta con la buccia, avere un frigorifero con cibo fresco, un letto e un bagno, e … poter usare la carta igienica (p. 108).
Qualche mese dopo, all’inizio di novembre, arriverà l’attesa chiamata dall’Ufficio immigrazione di Latina: è arrivato il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, il primo in Italia, rinnovabile e trasformabile in permesso di lungo soggiorno. Un buon viatico per il processo. Non che si tratti di un lieto fine. Nello stesso periodo, un giorno Balbir viene raggiunto da una telefonata dell’ex Padrone, che in seguito lo farà chiamare anche da altra persona: il padrone gli fa sapere di essere pentito, di voler fare la pace e dargli tutti i soldi che gli spettano … e propone quindi di darsi un appuntamento. Naturalmente Balbir capisce trattarsi di una trappola omicida, me la cosa crea gravi problemi comunque, a lui come a noi che leggiamo. Come ha fatto quell’imputato a procurarsi il numero di un cellulare consegnato al teste d’accusa dalle forze dell’ordine (e che naturalmente cambierà subito)?
La sentenza arriverà solo all’inizio del 2024, dopo che Balbir avrà tra l’altro fatto due esperienze di lavoro, la seconda delle quali, positiva e da lui chiaramente rimpianta, proprio in Lazio, a montare a terra pannelli fotovoltaici: è stato trattato bene, il lavoro era interessante, ma purtroppo è finita per mancanza di commesse. La prima suscita in noi un certo stupore: Balbir confessa schiettamente di esserci caduto ancora, di essere finito a lavorare in Piemonte alla raccolta delle noccioline e delle patate, questa volta attraverso le mene di un trafficante pakistano. Comunque, al netto delle condizioni di lavoro e sistemazione, è stato quanto meno pagato[14]. Anche se non lo dice chiaramente, l’impressione è che gli mancasse l’esperienza di un lavoro in squadra, di un minimo di vita di gruppo, la cosa su cui insiste e che apprezza ripensando all’esperienza piemontese, pur scusandosi con Omizzolo per essersene andato su due piedi senza spiegazioni.
La sentenza, condannando il padrone (di cui nel libro non viene mai fatto il cognome) e stabilendo anche una cifra (che non riavrà mai) di risarcimento, è un momento importante, non solo per Balbir ma per molti: in certo senso, si dovrebbe presumere, per tutta la comunità anche italiana del posto. Eppure Balbir e Omizzolo sono desolatamente soli al momento della lettura[15].
Nel frattempo il sikh ha ripreso il lavoro da bracciante, questa volta in regola, ma con aspetti da dejà vu (la sistemazione in container senza condizionatore e con impianto igienico poco funzionante)[16]. Di nuovo c’è qualcosa: un occhiuto sistema di controllo tramite telecamera. Contemporaneamente però la notizia della vittoria nel processo raggiunge gli organi di informazione, e non solo quelli. Balbir viene intervistato più volte, è invitato ad una iniziativa con Don Ciotti presso Fondi, poi chiamato in Vaticano a parlare della sua storia dall’associazione internazionale Walk Free Foundation. Nella stessa Latina, partecipa all’inaugurazione della statua “Le mani del rispetto”[17], con la presenza di autorità importanti. C’è però una conseguenza sgradevole: il nuovo padrone riconosce Balbir dalla foto sul giornale e gli chiede, con durezza, conferma[18]. Avutala, si intavola una discussione in cui costui gli fa presente che come straniero deve lavorare e basta, e che il suo ex-padrone sapeva perfettamente cosa faceva, e se lo trattava in un certo modo aveva delle buone ragioni. Alla risposta di Balbir, che rivendica il suo essere uomo libero, il padrone comincia a trattarlo male, e. scaduto il contratto, gli paga il dovuto comunicandogli ad un tempo il mancato rinnovo. Interessante quanto ci dice Balbir sul senso ad un tempo di felicità – quell’uomo, il datore di lavoro per intendersi, si è sentito minacciato da lui perché ha avuto il coraggio di lottare per i propri diritti, conosce il significato delle parole “contratto”, “dignità”, “libertà”, cosa evidentemente intollerabile ai suoi occhi - e nello stesso tempo di rabbia, per essere costretto a subire un discorso offensivo, manipolatore, teso a ripristinare la gerarchia, l’ordine vigente. Al momento del licenziamento, alla domanda di Balbir sul se la conclusione del contratto sia legata alla sua storia, gli risponderà che “solo gli ingrati denunciano” (sic!).
L’ultimo capitolo è un omaggio a Satnam Singh[19] e contiene riflessioni durissime, scaturite da una conoscenza di prima mano, sul comportamento del sindacato nell’agro pontino. Al pari del resto della comunità indiana, Balbir si sente strumentalizzato nella manifestazione indetta per la commemorazione, usato per una scadenza che dovrebbe essere la loro ma non lo è[20]. Si tratta, è il commento desolato, di un immigrato schiavo morto che potrà essere subito sostituito da un altro immigrato arrivato da chissà dove; il resto è resa dei conti tra soggetti “forti”, non solo italiani[21].
La conclusione, definitivamente a quattro mani, è sostanzialmente negativa: non solo, come dimostra il caso Satnam, c’è ancora molto lavoro da fare per consolidare alcune vittorie, come quella di cui Balbir stesso è stato protagonista. Vi è di più. La vocazione omicidiaria del padronato esce confermata, una schiera di avvocati e commercialisti sempre più scaltri ed abili copre i misfatti dell’Agro pontino (e non solo), mentre la divisione, diffusa ad arte, serpeggia anche tra sindacati e i braccianti stessi.
Cosa resta allora, se siamo ancora in pieno inverno e la primavera non è alle porte? Balbir risponde: La conquista della libertà, il restare liberi e ribelli.
****** ****************** *************************** ********
Il volume richiede una lettura su diversi livelli, per quanto essenzializzata.
I commenti al libro richiamati all’inizio sono tutti favorevoli, e ciò di per sé è un bene; ma il tono dei recensori è omogeneamente tra il sorpreso e l’indignato per quanto emerge dall’inchiesta condotta da Omizzolo (e resa possibile da Balbir), poi confermata da forze dell’ordine e magistratura, grazie in primo luogo alla testimonianza del secondo. Schiavitù nel cuore dell’occidente, in Italia, alle porte della Capitale? Ma chi avrebbe mai potuto pensare una cosa del genere! Temo che, al di là della qualità del lavoro di Omizzolo, esista in tutti noi, celata nell’animo, la contezza di cosa sta realmente avvenendo, la consapevolezza del dove stiamo andando. Schiavitù, (ritorno del) colonialismo, da sempre “corpo notturno” della democrazia d’occidente, escono dal cono d’ombra, sono drammaticamente rivendicate come valore, di qua e di là dall’Oceano[22]. Quelle grida di sorpresa sono in fondo ipocrisia, magari a fin di bene (nel senso di salvezza della propria anima); in una serie di casi, naturalmente, celano qualcosa di più grave.
Più in generale, pare di capire che anche nell’Agro Pontino la società del controllo si adegua velocemente agli standard della società della sorveglianza. Sarebbe bastato un sistema di videocamere – aggiunto all’esercito di avvocati e commercialisti che invadono la scena per suggerire ai loro clienti comportamenti non diversi, ma più “felpati” - per bloccare sul nascere lo stesso processo di liberazione di Balbir; l’occhio sempre vigile dell’ex-schiavo non manca di notare tale passaggio evolutivo. Gli elementi basilari, in fondo, sono già visibili nell’inizio e nella fine della vicenda. Balbir è attirato in sostanza in un trappolone, qualcuno lo avrà forse valutato – operaio nel pieno delle forze ma solo, privo di famiglia e di amici, con poca padronanza del linguaggio – nella sua prima esperienza lavorativa in Agro Pontino, giudicato idoneo per l’esperienza di schiavizzazione. Difficile sfuggire a questa sensazione. L’atmosfera cupa che circonda la prima parte della storia personale è magistralmente ripresa nelle pagine finali dal colloquio con l’imprenditore che lo licenzia. Mi pare ci siano – come dire? – non pochi elementi a favore dell’ipotesi che l’esperienza della schiavizzazione (semi-)formale risulta affatto interna a quel mondo imprenditoriale nel suo insieme. Questo sta piuttosto affilando i suoi strumenti di veloce modernizzazione, adeguamento ai canoni della società della sorveglianza. La forma-campo ne diviene allora, in forma più asettica probabilmente rispetto all’esperienza di cui è stato vittima Balbir, il tratto stabile. Tale forma campo, ricordiamo, emergeva nella sua forma completa già “nel momento di repressione delle lotte di resistenza contro il colonialismo”[23], ben prima che la seconda guerra mondiale lo importasse in Europa occidentale[24].
Resta, e non è poco, la resistenza, la lotta individuale di Balbir per non cedere, per non farsi mai cucire addosso l’accettazione del ruolo. Il momento chiave è quello di quando si accorge che i comportamenti in apparenza discontinui del padrone, il ricorso a mezzi di coercizione volta a volta differenti, sono unitariamente spiegabili con l’intento non solo di renderlo nei fatti, ma di farlo sentire uno schiavo, fargli accettare la dipendenza totale. La notte, illuminata dalle stelle, è il mondo di Balbir; il rapporto con gli animali, malgrado la durezza del lavoro, segno distintivo di una cultura che dà ampio spazio al rispetto di questi. E poi la visione del Circeo, e ancora, la notte dell’avventura del contatto, la visione della gatta bianca, personaggio meraviglioso della storia, che ricompare anche in seguito, ma non c’è il giorno della salvezza[25].
In parte, confesso, mi ci sono immedesimato. Tornava in evidenza il capolavoro di miei studi giovanili di (progettato) storico dell’afro-america, Lo schiavo americano dal tramonto all’alba,[26] ed insieme l’ebbrezza del contatto diretto con George Rawick il giorno della sua venuta a Padova quando raccontava della sua leggendaria opera di raccolta dei dati, la cena e la conversazione serale (nella forma di una tavola rotonda a Radio Sherwood se ben ricordo) con questa figura che nel ricordo incarna sempre di più la prospettiva del Maestro. Tutto ciò, ahinoi, avveniva ormai a ridosso del 7 aprile 1979. Ma ecco l’altro punto di contatto: nei primi giorni c’era un gatto, nei cortili dell’isolamento di Regina Coeli, che scendeva dai tetti a terra durante il mio breve periodo all’aria (lo faceva anche con gli altri arrestati in isolamento? Lo escludo, sono sicurissimo, scendeva certamente solo per me), rimaneva nei pressi e poi, quando era sicuro di aver catturato la mia attenzione, con due salti trovava il passaggio per i tetti, e si voltava a guardare se lo seguivo. L’indomani, paziente, tornava, pieno di buona volontà, ad insegnare la via della libertà all’allievo zuccone.
Avendo trovato da ultimo un tono più leggero rispetto alle tematiche tragiche su cui mi ero incamminato (prodigio della gatta bianca, ben s’intende), vorrei chiudere all’altezza, anche nell’individuazione del breve profilo critico al lavoro. Il punto è che Balbir è sikh, appartiene alla cultura che al mondo è forse la più attenta al rapporto uomo-(altri) animali, alcune uscite del libro anche relative al periodo di schiavitù sono perfettamente apprezzabili in tale ottica, o meglio solo in tale ottica. Forse quando il lavoro è diventato a quattro mani si poteva scavare di più, per sondare se questi tratti propri della sua cultura lo abbiano aiutato nel salvare il nocciolo della sua natura umana in un’esperienza di schiavizzazione calata in un mondo intriso di presenza animale. Insomma, un po’ mi dispiace non abbia potuto essere valorizzata appieno uno dei tratti salienti del suo essere sikh, l’empatia con gli altri animali.
Tutto qui? No, un’ultima cosa per finire. Ma si rende conto Marco Omizzolo della quantità di schifezze da mangiare che ha fatto trovare dentro il sacco nero quella notte? Lo vorrei interrogare sul perché di una simile perfidia. A meno che non ci fosse dietro un proposito didattico. Come a dire: vedi Balbir, oltre ai modi che tu hai conosciuto sulla tua pelle, c’è un'altra arma del padrone da cui ti devi guardare qui da noi, la distruzione delle persone tramite cibo-spazzatura da supermercato, la più subdola delle armi ….
[1] Omizzolo M. e Singh B., Il mio nome è Balbir, ed. People, Busto Arsizio, 2024.
[2] V, l’intervista fatta di Lorenzo Misuraca, pubblicata sul sito Il salvagente in data 9 gennaio 2025.
[3] Il primo tra i rarissimi passaggi in cui l’interlocutore di un dialogo continuo è chiamato per nome.
[4] Tale stato di sospensione è studiato a fondo, per quanto riguarda il colonizzato, da Frantz Fanon, e opportunamente ripreso da Achille Mbembe nel suo fondamentale Politique de l’inimitié. V. Mbembe A. Nanorazzismo. Il corpo notturno della democrazia, VI ed., Laterza, Bari, 2019, che dedica l’intero cap. terzo (p. 81 ss.) alla “farmacia di Fanon”. V. anche oltre, nota…
[5] E avvalendoci di clamorosi quanto terribili fatti di cronaca (v. oltre).
[6] “10 aprile 2017. Schiaffi, pugni e un dolore che non passa”, è il titolo dell’ultimo dei capitoli iniziali.
[7] Una fame voluta, imposta, articolazione-chiave del progetto di fare di quei braccianti degli schiavi.doc.
[8] Che gli schiavi procederanno immediatamente a scaricare, tra le urla e spesso le botte: uno stato di servitù manifesta dunque, anzi ostentata.
[9] Composto da due scimitarre, un pugnale centrale a doppia lama, e un disco. Il pugnale a doppia lama, ci spiega Balbir, rappresenta l’onnipotenza di Dio; il disco, che lo comprende, rappresenta l’infinito e la perfezione di Dio; le sciabole esterne significano “l’equilibrio spirituale e temporale che regola l’universo” (p. 57).
[10] Inizialmente, per euforia e nello stesso tempo darsi forza, Balbir continua a bere whisky all’inizio del colloquio notturno, e Marco, all’altro capo del telefono, fa lo stesso. In realtà, come ha spiegato in più interviste il sociologo, fa finta di bere alcool con lo schiavo, per aumentare il senso di coinvolgimento. Atteggiamento che può parere di superiorità, ma in realtà costituisce il passo iniziale verso una comunanza di percorso, anche per la situazione nuova rappresentata dallo status di Balbir, che richiede di pensare ad articolare una soluzione su più fronti. Questa acquisita bilateralità è confermata dal fatto che Omizzolo racconta a Balbir, nel corso dei colloqui, esperienze assai riservate, relative alla pregressa attività da infiltrato tra gli schiavi dell’agro pontino, fino all’esperienza più celata, relativa a quando ha seguito fino in India un trafficante di esseri umani.
[11] Trovo curioso come nelle pagine del libro non compaia mai tra le ipotesi prese in esame la soluzione (si fa per dire) che sarebbe la più prossima alla mente di un europeo il quale fosse ridotto in quello stato, mantenendo al contempo, come Balbir, scatti vitali di ribellione: uccidere comunque il persecutore per poi, all’evenienza, togliersi la vita. Per il sikh le due soluzioni sono descritte e confrontate, sempre, come reciprocamente esclusive: non mi pare questione di mancanza di fantasia, quanto di implicazioni etiche opposte nelle due scelte.
[12] Qui si colloca una digressione del terzo autore, quello a quattro mani, che sviluppa un ragionamento sui corsi di italiano per stranieri e sulle vere e proprie truffe che spesso questi nascondono, anche quando sono agiti da enti no-profit, e non solo italiani.
[13] “Il permesso di soggiorno, già lo sappiamo, non è solo un documento, un atto amministrativo.
[14] Ovviamente una quota del salario va a chi ha procurato il lavoro, e l’affitto al presunto proprietario della baracca.
[15] Seguono alcune osservazioni tra il disilluso e lo sprezzante sul comportamento di politici e sindacalisti. Non ho indicazioni, ma attribuirei anche queste al terzo autore, quello che scrive a quattro mani.
[16] C’è comunque un altro bracciante, un indiano irregolare; così al verificarsi di una ispezione, il padrone dice a Balbir di andare a spiegare all’altro, che non parla italiano, di rendersi irreperibile scappando per campi.
[17] Poi regolarmente vandalizzata, come da copione.
[18] Gli chiede anche se conosca Omizzolo; la rivendicazione di un rapporto fraterno è forse l’elemento decisivo ai fini della conclusione del rapporto di lavoro.
[19] Il titolo è “L’omicidio di Satnam Singh e la nostra primavera che tarda ad arrivare”. Si tratta dell’operaio vittima il 17 giugno 2024 di un incidente in una azienda della campagna di Latina (a pochi chilometri da dove si è svolta la cupa vicenda di Balbir), con un macchinario che gli tronca un braccio di netto. Due giorni dopo morirà all’ospedale S. Camillo di Roma “dopo che il sum padrone lo aveva portato con il suo furgone davanti a casa per scaricarlo come un sacco, insieme alla moglie e al braccio mozzato, messo dentro una cassetta per la frutta”.
[20] “Sul palco non c’era un solo bracciante indiano del Pontino. Provenivano tutti da altre regioni. Ci hanno espropriato del diritto di manifestare e scioperare per Satnam. Ci hanno usato per scioperare per loro, non per Satnam”. (p. 131).
[21] La situazione è aggravata dal fatto che c’era una situazione di caporalato nota agli organi dello Stato da anni: orbene, non solo non era stato fatto nulla per porvi rimedio, ma l’impresa aveva continuato a ricevere fondi pubblici dallo Stato.
[22] Potremmo quasi dire che quel padrone, anzi Padrone, è figura attualissima, incarna - con alcune cadute macchiettistiche certo, da old fascism - il terribile passaggio in atto; è insomma degno compagno di strada del colono israeliano come delle forze civili e paramilitari ad un tempo (le “formazioni di terrore” di cui parla Mbembe) che un po’ dovunque si vengono occupando del lavoro sporco ai confini, dell’Europa come della potenza d’oltre Atlantico.
[23] Mbembe A, cit., p. 89.
[24] Sulla forma campo europea si è soffermata inizialmente Hannah Arendt: “L’inferno non è più una credenza religiosa o una fantasia, bensì qualcosa di reale, quanto lo sono le case, le pietre e gli alberi. Sembra che nessuno voglia capire che la storia contemporanea ha creato una nuova specie di esseri umani – quelli che vengono messi nei campi di concentramento dai loro amici e nei campi di internamento dai loro amici”. Arendt H., Noi rifugiati, Einaudi, Torino, 2022, p. 6.
[25] È bellissimo che Balbir, pur nella tempesta emotiva che lo agita all’arrivo dei carabinieri, trovi il modo di notare l’assenza della gatta, messaggera di salvezza. Il punto è che non era più necessaria, il suo compito era finito, si è ritirata con discrezione, come, appunto, solo una gatta messaggera di salvezza sa fare.
[26] Rawick G., Lo schiavo americano dal tramonto all’alba, Feltrinelli, Milano, 1973, ora ripubblicato da Derive Approdi, Roma, 2022, con prefazione di Bruno Cartosio. Naturalmente Rawick investiga sulla capacità difensiva di una comunità in catene, che trova la sua manifestazione nella capacità di darsi una vita notturna, fuori dagli occhi dei sorveglianti, umana quindi per quanto è possibile nell’universo disumano della piantagione. Balbir, in totale solitudine, grida la sua umanità alla notte, per averne conferma.